L’economia europea si trova a fronteggiare sfide che potrebbero influenzare la sua crescita, stabilità e competitività. Con l’invecchiamento della popolazione l’UE sta affrontando una riduzione della forza lavoro e un aumento della pressione sui sistemi di previdenza sociale. In parallelo, il Green Deal e la neutralità climatica richiedono significativi investimenti, ma la mancanza di risorse sta rallentando la competitività delle grandi imprese europee.
In questo contesto la robotica si sta dimostrando una soluzione strategica per superare queste complessità. Ne abbiamo parlato con Bruno Siciliano, uno dei massimi esperti di questo settore, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione all’Università Federico II di Napoli.
Quali sono stati i progressi più significativi nell’interazione persona-robot negli ultimi anni? E qual è il contributo dell’AI allo sviluppo della robotica?
«Uno dei progressi più rilevanti negli ultimi anni è stato lo sviluppo dei robot collaborativi, o cobot, progettati per lavorare insieme agli esseri umani in sicurezza. Se in passato i robot erano confinati dietro barriere di protezione, oggi condividono lo spazio con gli esseri umani grazie a sensori avanzati che permettono loro di “sentire” e “vedere” l’ambiente circostante rendendo le loro interazioni più naturali e precise. La loro capacità di adattarsi e interagire in modo sicuro e intuitivo è stata migliorata dall’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale (AI), che consentono di percepire la presenza umana e reagire in tempo reale a situazioni impreviste. Questo ha permesso di estendere il loro utilizzo dal contesto industriale in settori come la logistica, la sanità e l’agricoltura, per menzionare alcuni settori che hanno riscontrato un grande sviluppo negli ultimi anni. Allo stesso tempo, i progressi nel riconoscimento vocale e nell’elaborazione del linguaggio naturale hanno reso i robot più efficaci nella comunicazione con le persone. L’AI e l’apprendimento automatico hanno inoltre reso i robot più versatili, permettendo loro di operare in ambienti meno strutturati, come case e uffici, e di contribuire in settori come l’ospitalità».
I cambiamenti socio-economici stanno influenzando il mondo della robotica? Dove ci stiamo dirigendo?
«I rapidi cambiamenti demografici ed economici stanno trasformando profondamente la società, ma anche le tecnologie avanzate, come la robotica e l’AI, insieme al più ampio processo di transizione digitale, stanno influenzando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo. Questa relazione è circolare: da un lato, le esigenze sociali e produttive, come la necessità di sostenibilità, inclusione e resilienza economica, spingono verso lo sviluppo e l’adozione di tecnologie sempre più avanzate. Dall’altro, la diffusione di queste innovazioni sta rimodellando profondamente le strutture sociali, economiche e culturali. Durante il recente Forum WPP | The European House ‒ Ambrosetti, è stato evidenziato come la robotica e l’AI non siano solo strumenti per sostituire compiti ripetitivi o gravosi, ma rappresentino una leva per amplificare le capacità umane, migliorare l’efficienza e la sicurezza e rivoluzionare settori come la sanità, la logistica e la manifattura. Parallelamente, il processo di transizione digitale sta accelerando la capacità delle organizzazioni di gestire dati, innovare nei servizi e adottare modelli di lavoro più flessibili e interconnessi. Questa doppia dinamica ― l’adozione di tecnologie emergenti e il consolidarsi della digitalizzazione ― richiede una gestione attenta per bilanciare progresso tecnologico e inclusione sociale. Le innovazioni, se non integrate con criteri di sostenibilità ed equità, rischiano di amplificare le disuguaglianze economiche e sociali esistenti. Per questo, diventa fondamentale investire nello sviluppo del capitale umano, promuovendo istruzione e formazione che preparino le persone a cogliere le opportunità offerte da queste trasformazioni».
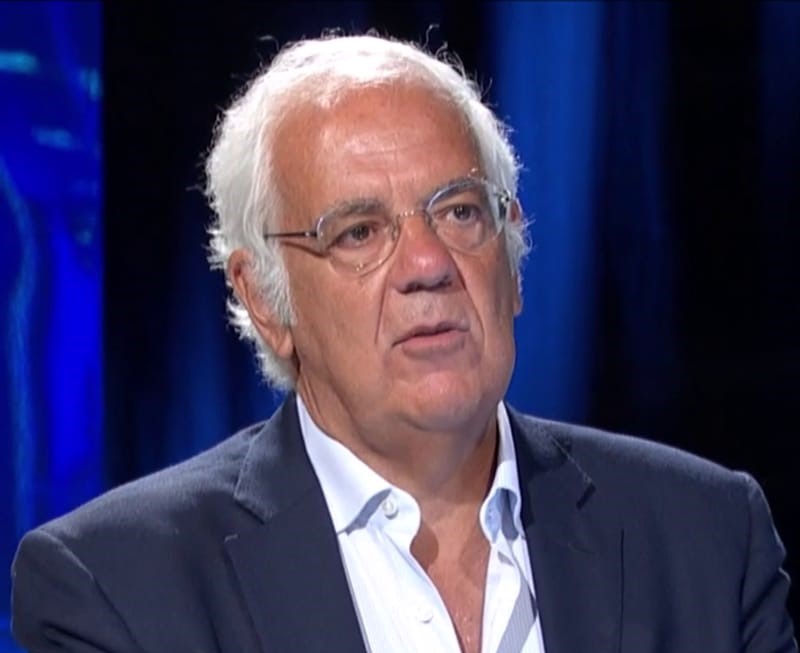
Bruno Siciliano-esperto robotica
La robotica quanto aiuterà la crescita economica mondiale?
«La robotica è destinata a svolgere un ruolo cruciale nella crescita economica mondiale, offrendo soluzioni innovative per aumentare la produttività, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi operativi. La Robotic Process Automation (RPA), una delle tecnologie più in crescita, ne è un esempio emblematico: il mercato globale dell’RPA è previsto crescere da 10 miliardi di dollari nel 2022 a 43,5 miliardi entro il 2029, con un tasso annuo di crescita del 23,4% (dati di Fortune Business Insights). Questo riflette il crescente interesse delle aziende verso l’automazione per competere in un contesto globale sempre più complesso. L’RPA e, più in generale, la robotica, consentono di semplificare e ottimizzare processi operativi complessi, riducendo errori, migliorando l’efficienza e liberando risorse umane per attività strategiche e creative. Questo si traduce in un aumento della produttività aziendale e in una maggiore competitività, che a sua volta può contribuire alla crescita economica globale. Tuttavia, la crescita economica non dipende esclusivamente dalla robotica o dall’automazione. Variabili fondamentali come il capitale umano, le politiche economiche e fiscali, l’innovazione e la stabilità geopolitica giocano un ruolo altrettanto cruciale. Per esempio, l’automazione crea opportunità significative, ma richiede investimenti paralleli in istruzione e formazione per garantire che la forza lavoro sia in grado di sfruttare appieno i benefici di queste tecnologie. Inoltre, un quadro normativo favorevole e la promozione di un’innovazione inclusiva sono essenziali per garantire che i benefici siano distribuiti equamente. In definitiva, la robotica rappresenta un motore chiave per la crescita economica mondiale, ma deve essere considerata come parte di un ecosistema più ampio».
Quanto si sta investendo oggi nello sviluppo della robotica? L’Italia com’è messa?
«Gli investimenti nello sviluppo della robotica continuano a crescere a livello globale, sostenuti dalla crescente automazione in settori chiave e dalle sfide economiche e sociali che richiedono soluzioni tecnologiche innovative. Secondo i dati della International Federation of Robotics (IFR), nel 2022 si è registrato un nuovo record con oltre 553.000 robot industriali installati, un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Lo stock operativo globale di robot industriali ha raggiunto quasi 3,9 milioni di unità, con una crescita media annua del 13% dal 2017. In Europa, l’Italia si posiziona al sesto posto mondiale per numero di installazioni di robot industriali, con una crescita dell’8% nel 2022 e 11.475 unità installate, pari al 16% del mercato europeo. Tuttavia, il Paese destina solo l’1,1% del PIL alla ricerca e sviluppo, una percentuale decisamente inferiore alla media OCSE».
Parliamo di applicazioni. Quanto sono utilizzati oggi i robot ed in quali ambiti?
«Oggi i robot sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di settori, con una crescente diffusione sia nell’ambito industriale sia nei servizi. Secondo i dati dell’International Federation of Robotics (IFR), il settore industriale è quello con la maggiore presenza di robot, utilizzati per automatizzare i processi produttivi e supportare l’uomo in operazioni pesanti, ripetitive o ad alta precisione. I principali settori industriali che impiegano robot sono: automotive, elettronica ed elettrotecnica, manifatturiero meccanico e metallurgico, plastica e chimica, alimentare. Nel 2022, le vendite di robot di servizio hanno registrato una crescita significativa, con un aumento del 48% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 158.000 unità destinate all’uso professionale. Questa crescita è stata fortemente influenzata dalla carenza di personale, che ha spinto molte aziende ad automatizzare processi in diversi ambiti. Per esempio, nel settore del trasporto e della logistica, oltre 86.000 robot sono stati impiegati, con molti di questi dedicati alla consegna di cibo e bevande. Anche l’ospitalità ha visto una crescita eccezionale, con più di 24.500 unità vendute per funzioni come guida mobile, informazione e telepresenza. Nel campo medico, mentre le vendite di robot chirurgici hanno raggiunto quasi 4.900 unità, si è osservato un calo nelle tecnologie per la riabilitazione e le terapie non invasive. Al contrario, l’agricoltura ha visto una crescita del 18%, con quasi 8.000 robot utilizzati principalmente per attività come mungitura e pulizia delle stalle, rispondendo così alla crescente necessità di sostenibilità in contesti agricoli. Anche la pulizia professionale ha registrato una crescita, con la maggior parte dei robot utilizzati per la pulizia dei pavimenti. Per quanto riguarda il mercato consumer, le vendite hanno raggiunto numeri impressionanti, con 5,1 milioni di robot domestici venduti. Tra questi, i robot aspirapolvere hanno dominato il segmento, affermandosi ormai come una presenza comune nelle abitazioni, seguiti dai robot tagliaerba e da quelli dedicati all’interazione sociale e all’educazione. Infine, l’integrazione con l’AI sta trasformando le applicazioni robotiche. I robot stanno diventando sempre più “smart”, in grado di apprendere dai dati raccolti per ottimizzare le prestazioni, sia in contesti industriali che in ambiti assistenziali e sociali».
Ci sono rischi per l’uomo? Cioè in alcuni ambiti lavorativi l’essere umano sarà completamente sostituito dal robot?
«Il progresso tecnologico comporta inevitabilmente il rischio di una sostituzione in alcune mansioni, specialmente quelle caratterizzate da un basso livello di specializzazione o da compiti standardizzati. È una trasformazione che accompagna ogni fase di innovazione tecnologica nella storia. La robotica, in particolare, sta automatizzando rapidamente molti compiti in settori come l’industria manifatturiera e la logistica. Tuttavia, questa automazione non è solo sinonimo di perdita di posti di lavoro, ma crea anche nuove opportunità lavorative, legate alla programmazione, alla manutenzione e alla gestione dei sistemi robotici. In ambiti come la sanità, l’educazione o l’assistenza, l’interazione tra uomo e macchina è importante, ma qui il ruolo umano è insostituibile per garantire un approccio empatico e personalizzato, aspetti che la tecnologia non può replicare. È per questo che il vero focus della robotica deve essere sulla collaborazione uomo‒macchina, sfruttando le capacità uniche dell’intelligenza umana, come la creatività e l’intuizione, insieme alla precisione e all’efficienza dei robot. Non si tratta solo di una sfida tecnologica, ma di una vera e propria sfida sociale, economica e culturale. La domanda cruciale non è se i robot sostituiranno gli esseri umani, ma come la società potrà essere preparata a un mondo in cui uomo e robot convivono, collaborano e si completano. Questa transizione richiederà investimenti significativi in istruzione, formazione e politiche di inclusione per garantire che i benefici della robotica siano distribuiti equamente. I robot non devono essere visti come una minaccia, ma come strumenti capaci di migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi sul lavoro. Se sviluppati e impiegati con una visione inclusiva e sostenibile, possono rappresentare una straordinaria opportunità per il progresso umano, valorizzando le capacità distintive di ciascun individuo e liberando risorse per compiti più creativi e strategici».
Qual è la vera sfida, il controllo?
«Il controllo rappresenta la vera sfida della robotica moderna, poiché consente ai robot di agire in modo autonomo, sicuro ed efficace. La robotica è definita come la “connessione intelligente tra percezione e azione”, resa possibile da un sistema di controllo avanzato. Rispetto al passato, quando i robot eseguivano una semplice sequenza predefinita di movimenti, oggi le loro azioni sono governate da sistemi di controllo che permettono di adattarsi dinamicamente a ciò che accade nell’ambiente, secondo il principio del feedback, simile a quello che regola le funzioni del corpo umano. Questo processo si basa su tre aspetti fondamentali: il robot raccoglie informazioni dall’ambiente attraverso sensori avanzati, elabora i dati per pianificare le azioni e, infine, traduce queste decisioni in movimenti precisi e controllati. È questa capacità di connessione intelligente che consente ai robot di interagire con il loro contesto in modo efficace. In questo scenario, il concetto di InterAction Technology (IAT) segna una svolta cruciale. Se in passato i robot erano confinati in spazi separati dagli esseri umani per ragioni di sicurezza, oggi le tecnologie di interazione li trasformano in cobot, ovvero robot collaborativi che lavorano fianco a fianco con i lavoratori in maniera sicura e affidabile. Questi robot non solo si adattano agli ambienti variabili e incerti, ma offrono un contributo significativo anche al miglioramento della qualità della vita. Questa trasformazione sarà resa possibile grazie a tecnologie sempre più intuitive. Sensori avanzati e potenti capacità di elaborazione consentiranno ai robot di comprendere e adattarsi meglio all’ambiente circostante. Inoltre, l’introduzione del 5G abiliterà connessioni wireless ultra-rapide e stabili, necessarie per il controllo dinamico e in tempo reale. L’avvento del 5G ha aperto inoltre la strada a concetti come l’Internet of Skills (IoS), una tecnologia che combina le competenze umane con quelle robotiche, consentendo applicazioni come la chirurgia a distanza o il controllo in tempo reale di macchine complesse. Dunque, il controllo non è solo un elemento tecnico ma rappresenta la chiave per trasformare i robot da strumenti rigidi a partner intelligenti. Questo progresso tecnologico non solo rivoluzionerà i processi industriali ma investirà molto in altri settori».
Quando sarà veramente normale, semmai lo sarà, lavorare o vivere con un robot al fianco? Penso al famoso film con Robbie Williams, “L’uomo bicentenario”, ma da allora sono passati quasi 30 anni …?
«La rappresentazione cinematografica della tecnologia riflette e alimenta il nostro immaginario collettivo, portando sullo schermo le sfide e i dilemmi che l’umanità affronta nel rapporto con le proprie creazioni. La stessa robotica come scienza, è profondamente intrisa di queste narrazioni. La robotica moderna nasce proprio dall’incontro tra le narrazioni mitologiche e la fantascienza. In Frankenstein di Mary Shelley e in R.U.R. Rossum’s Universal Robots di Karel Čapek, il tema della ribellione della creatura al suo creatore riflette la tensione tra l’uomo e le sue stesse invenzioni. Invece, con Isaac Asimov avviene un cambiamento significativo. L’introduzione delle Tre Leggi della Robotica sposta la narrativa dal conflitto verso la cooperazione. Asimov immagina robot progettati per essere collaborativi e sicuri, costruendo un’immagine positiva di queste macchine come alleati dell’uomo. Le sue idee hanno avuto un impatto così profondo, che le discussioni etiche e giuridiche contemporanee sulla robotica spesso si rifanno a questo quadro normativo, con l’Unione Europea che cita esplicitamente le Tre Leggi nella documentazione relativa alla regolamentazione del settore. La società continua a percepire i robot come una promessa futura, influenzata dall’immaginario fantascientifico che li associa a macchine umanoidi dotate di intelligenza artificiale avanzata. Questo spiega perché, nonostante la presenza quotidiana di tecnologie robotiche di uso comune, il pubblico tenda a identificare i robot con figure antropomorfe. La fantascienza, con i suoi simboli e narrazioni, ha contribuito a questa distanza tra percezione e realtà, focalizzandosi spesso su temi come la coscienza e l’autonomia piuttosto che sulle applicazioni pratiche della robotica. La crescente presenza dei robot nella nostra società solleva interrogativi concreti e urgenti. Il vero tema, man mano che i robot assumono un ruolo attivo nelle nostre vite, è l’interazione uomo–robot che apre una moltitudine di domande. Qui entra in gioco la roboetica, un campo interdisciplinare che si occupa di analizzare e affrontare le implicazioni etiche, legali e sociali della robotica. Questa disciplina pone interrogativi fondamentali su temi come la responsabilità, l’autonomia e il controllo. In un mondo in cui i robot possono agire in modo sempre più indipendente, è essenziale stabilire standard etici e regolamentazioni che ne governino l’uso, prevenendo potenziali abusi e garantendo che il loro impiego rispetti la dignità umana. Questi interrogativi assumono particolare rilevanza in ambiti come il mercato del lavoro, dove l’automazione rischia di ampliare le disuguaglianze, o in contesti militari, dove l’uso di armi autonome solleva preoccupazioni etiche senza precedenti. La roboetica, nata proprio in Italia, promuove una riflessione interdisciplinare che coinvolge ingegneri, filosofi, giuristi e sociologi, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo tecnologico verso una direzione che integri innovazione e valori umani fondamentali, garantendo un futuro più equo e sostenibile».
Secondo lei quale sarà il futuro della robotica, i droni?
«Il futuro della robotica è strettamente legato a molte tecnologie emergenti, e i droni rappresentano una delle aree più innovative e promettenti. La robotica aerea, in particolare, si è consolidata come un campo di ricerca avanzato, integrando modellazione, controllo, percezione, pianificazione, manipolazione e design. Questi sistemi sono già utilizzati per una varietà di applicazioni, come l’ispezione e la manutenzione di infrastrutture difficili da raggiungere, la ricerca e il soccorso in situazioni di emergenza, il trasporto e la consegna di materiali, il monitoraggio ambientale e la creazione di mappe tridimensionali. La loro capacità di operare in ambienti complessi e pericolosi, riducendo rischi, tempi e costi, li rende strumenti indispensabili per il futuro. Grazie al livello di maturità raggiunto, i droni stanno evolvendo verso una nuova generazione di robot di servizio volanti. Questi dispositivi saranno sempre più capaci di interagire attivamente e in sicurezza con l’ambiente, supportando l’uomo in attività complesse, come la manipolazione aerea, che include la capacità di afferrare, trasportare e posizionare oggetti direttamente dal drone stesso. Questo apre prospettive in scenari avanzati, come la raccolta di campioni in luoghi remoti o la manutenzione di strutture meccaniche inaccessibili».
Secondo Siciliano quindi il futuro della robotica non si limiterà ai droni o agli ambienti industriali. È al di fuori delle fabbriche che si svilupperanno le applicazioni più interessanti, perché ogni progresso significativo avverrà nelle intersezioni con altre discipline. Realtà virtuale, machine learning, prototipazione avanzata, reti di sensori, biomeccanica, neuroscienze, medicina, sociologia e persino filosofia della scienza sono solo alcune delle aree che saranno contaminate e arricchite dalla robotica. Questo dialogo tra discipline apparentemente distanti non solo favorirà nuove applicazioni, ma sarà una fonte costante di ispirazione e innovazione.