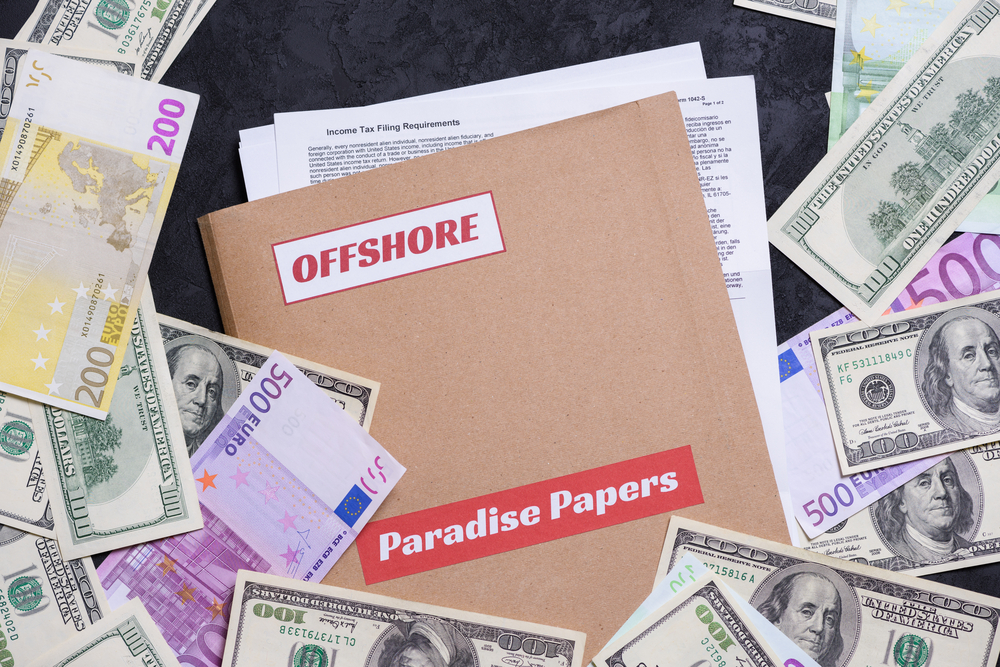Le disuguaglianze rappresentano un tratto tristemente distintivo dell’epoca in cui viviamo. Le recenti gravi crisi, infatti, non hanno fatto altro che ampliare le disparità e le fratture sociali, inaugurando quello che Oxfam non stenta a definire come il “decennio di grandi divari” con miliardi di persone costrette a vedere crescere le proprie fragilità e a sopportare il peso di epidemie, carovita, conflitti, eventi metereologici estremi sempre più frequenti e una manciata di super-ricchi che moltiplicano le proprie fortune a ritmi parossistici. Di questo, come di molti altri temi riguardanti le disuguaglianze, ha parlato Misha Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale di Oxfam Italia, intervistato dal nostro direttore editoriale Matteo Vallèro negli studi di Business24.
Partiamo da una fotografia su ricchezza e povertà in Italia: quanto è squilibrata la distribuzione di ricchezza nel nostro Paese? E quanto la povertà è prossima al livello di guardia?
«Il nostro Paese ha conosciuto un andamento di crescita della concentrazione della ricchezza al vertice della piramide sociale. In poco più di 20 anni lo 0,01% più ricco dei nostri connazionali, circa 5000 adulti titolari di patrimoni netti superiori a 20 milioni di euro, ha visto la quota della propria ricchezza nazionale quasi raddoppiare. E’ un periodo, quello a metà degli anni 90 e metà degli anni 10, che noi tendiamo a definire il periodo dell’inversione delle fortune. La quota di ricchezza del 10% più ricco degli italiani è andata crescendo e la quota di ricchezza posseduta dal 50% dei più poveri è diminuito. Parlare di disuguaglianza e ricchezza significa parlare di strutture, di cittadinanza e opportunità all’interno della società. La ricchezza misura la resilienza di un Paese, la capacità di reagire a shock di spesa improvvisi o programmati, perdita di un lavoro o potenzialità di investire nel proprio futuro. Le persone ricche hanno migliori opportunità di accedere a percorsi di studio migliori, così come opportunità occupazionali e accesso al credito. La cosa più preoccupante è dover dire che nel nostro Paese la trasmissione generazionale delle disuguaglianze è molto marcata e in Italia questo fenomeno è, purtroppo, molto marcato. Quindi non è sbagliato affermare che in Italia i ricchi sono i figli dei ricchi e i poveri sono figli dei poveri. Parliamo di ascensore sociale bloccato con pavimenti ma anche soffitti appiccicosi».
Quali sono le ragioni dietro il marcato aumento delle disuguaglianze economiche in Italia negli ultimi decenni?
«In Italia come in altre economie avanzate negli ultimi 4 decenni le disuguaglianze di reddito e ricchezza economiche sono aumentate considerevolmente, le cause sono diversissime. Da un lato un ruolo importante ha giocato l’ascesa della finanza, favorita da restrizioni sui controlli dei flussi di capitali, la deregolamentazione delle attività bancarie e liberalizzazione delle istituzioni finanziarie. La finanza ha offerto nuovi strumenti, nuove opportunità e campi di applicazione che hanno fatto aumentare i valori dei patrimoni ma anche aperto la strada a speculazione a breve periodo. Tra le altre cause, il potere di mercato in molti segmenti si è concentrato sempre di più, è stata una scelta politica. Nel settore della farmaceutica ora esistono una decina di Big Farm, per fare solo un esempio. Un’ultima causa è l’arretramento della politica, si è concentrata sempre meno su ciò che avrebbe potuto migliorare il benessere delle classi meno abbienti: la progressività fiscale, il controllo degli affitti, politiche di inclusione socio-lavorativa o contrasto a vantaggi ingiustificati».
Come le grandi imprese incidono sulla dinamica della disuguaglianza?
«Hanno acquisito un potere di mercato esorbitante, le prime 10 major internazionali hanno un valore di mercato di capitalizzazione superiore a decine del pil di paesi più poveri. Questa crescita delle disuguaglianze sarebbe stata nettamente inferiore se la conduzione delle imprese avesse avuto maggiore attenzione agli interessi conflittuali degli stakehoder, azionisti, fornitori e clienti, perfino le comunità intorno agli stabilimenti produttivi. Ciò non è stato fatto. Dalla metà degli anni ’70 è stato incentivato un modello di impresa incardinato sul principio della massimizzazione dei profitti o meglio del valore economico per gli azionisti. Portando a un allineamento degli interessi dal top management e la proprietà, gli ha portato capitali di rischio a discapito di una più equa creazione e condivisione del valore creato a cui compartecipano attori diversi, spesso premiando una redditività a basso termine ottenuta tagliando costi del lavoro o delocalizzando aziende».
L’intervista completa a Misha Maslennikov (Oxfam Italia) è andata in onda sul canale 410 del digitale terrestre
Disuguaglianze e cambiamenti climatici sono, nella denuncia di Oxfam, due fenomeni intrecciati. Ce ne spiega il nesso?
«C’è una disuguaglianza nelle responsabilità per le emissioni clima alteranti. I paesi più ricchi e gruppi sociali più ricchi hanno un’incidenza delle emissioni maggiore per quanto riguarda il loro stile di vita e di consumo, ma anche per i loro investimenti nei comparti fossili. C’è anche una capacità di adattamento e reazione diversa tra Paesi più ricchi e quelli più poveri. Se questa è l’epoca in cui dobbiamo pensare a progetti robusti per la riduzione delle emissioni, abbiamo anche bisogno di renderci conto che transizioni del genere hanno costo sociali elevati e creano disparità. Nessuno deve rimanere indietro e bisogna attuare miusre che non acuiscano ancora di più le disuguaglianze».
Quali sono gli effetti negativi che le elevate e crescenti disuguaglianze producono sull’economia e sulla società? E quali provvedimenti dovrebbero essere messi in campo dai Governi per ricucire i divari economici e sociali?
«Gli impatti delle disuguaglianze sull’impatto sociale è quello su cui dovrebbe occuparci tutti. Mentre alcuni fanno balzi in avanti verso un futuro luminoso e altri scendono in terreni fragili, cresce la disaffezione verso la politica e cresce anche la spinta ad accettare proposte populiste fino a arrivare alle derive autoritarie. Le disuguaglianze hanno quindi anche un effetto sulle nostre vite democratiche. L’inflazione non ha aiutato e ha avuto responsabilità a non permetterci di abbassare i livelli di povertà, nella fase post covid mentre riprendevano i consumi, l’inflazione ha eroso i redditi. Tra l’altro sappiamo che l’inflazione è una tassa sui poveri, perché colpisce chi ha redditi fissi e più bassi, persone i cui redditi dipendono dai trasferimenti pubblici, che spesso non sono indicizzati all’inflazione stessa».
Come si esplicita l’impegno di Oxfam nel contrasto a povertà e disuguaglianze: quali progetti e iniziative avete o state mettendo in atto?
«Siamo un attore di welfare comunitario, abbiamo centri territoriali in cui supportiamo i cittadini in vari ambiti. Li aiutiamo ad accedere alla pubblica amministrazione e supportiamo inclusione socio-lavorativa e siamo molti impegnati nella dispersione scolastica e povertà educativa. Abbiamo anche nella nostra azione una forte valenza politica, esiste una agenda per l’uguaglianza che Oxfam propone con proposte che possono permetterci di costruire società, non in cui proponiamo un livellamento sociale, ma più eque, coese e dove sia più facile poter realizzare le proprie aspirazioni».
I divari economici e sociali preoccupano, alimentando un diffuso sentimento di frustrazione, impotenza e perdita di controllo sul futuro. Non si può però normalizzare le persistenti disparità o considerarle come un fenomeno casuale ed ineluttabile. Le disuguaglianze, come è stato ampiamente spiegato da Oxfam, sono piuttosto il risultato di scelte o, spesso, delle non-scelte della politica che hanno prodotto negli ultimi decenni profondi mutamenti nella distribuzione di risorse, dotazioni, opportunità e potere tra gli individui.